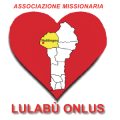VALLE SAUGLIO - Un’esperienza in un centro di seconda accoglienza siciliano, un modo differente per trascorrere le vacanze. Protagonisti di questa avventura fuori dal comune sono un gruppo di giovani di Valle Sauglio che hanno trascorso 10 giorni a Canicattini Bagni in Sicilia dal 3 al 14 agosto. Davide Lucchetta 23 anni, studente universitario di scienze internazionali, proiettato verso questo tipo di esperienza, racconta l’avventura che ha vissuto insieme ad alcuni suoi coetanei: il fratello Fabio Lucchetta, Pietro Lavezzo, Gregorio Lavezzo, Lorenzo Dughera, Samuele Ruffino, Elisa Testa ed Elena Turetta.
VALLE SAUGLIO - Un’esperienza in un centro di seconda accoglienza siciliano, un modo differente per trascorrere le vacanze. Protagonisti di questa avventura fuori dal comune sono un gruppo di giovani di Valle Sauglio che hanno trascorso 10 giorni a Canicattini Bagni in Sicilia dal 3 al 14 agosto. Davide Lucchetta 23 anni, studente universitario di scienze internazionali, proiettato verso questo tipo di esperienza, racconta l’avventura che ha vissuto insieme ad alcuni suoi coetanei: il fratello Fabio Lucchetta, Pietro Lavezzo, Gregorio Lavezzo, Lorenzo Dughera, Samuele Ruffino, Elisa Testa ed Elena Turetta.
«Spesso ci dimentichiamo che questi ospiti dei centri sono fondamentalmente persone. È questa la parola che ci dimentichiamo di usare quando trattiamo il delicato tema dell’immigrazione. Immigrati, clandestini, profughi, richiedenti asilo, irregolari, extracomunitari, rifugiati, tutte categorie che, anche in maniera errata, utilizziamo per definirli ed etichettarli, dimenticandoci di ciò che sono prima di essere tutto ciò: persone. Persone, ragazzi che hanno il diritto di godere del rispetto della loro dignità umana al pari di qualsiasi altro essere umano su questo pianeta – esordisce Davide che dopo gli studi vorrebbe intraprendere la carriera diplomatica o comunque lavorare in ambito internazionale, ONG o enti istituzionali – È questo l’approccio con cui abbaiamo vissuto i dieci giorni nel piccolo centro di seconda accoglienza per minori di Canicattini Bagni in Sicilia dal 3 al 14 agosto. Non sapevamo bene quello a cui saremo andati in contro, ma il nostro obiettivo, a prescindere da qualsiasi altra cosa, rimaneva uno: portare a quei ragazzi una piccola  speranza, una speranza per farli sentire degni di vivere una vita lontano dalla necessità di lasciare la loro terra, la famiglia, gli affetti più cari, affrontando viaggi estenuanti, torture e difficoltà inimmaginabili per arrivare in un posto in cui tutti sono preoccupati di dar loro un’etichetta, ma pochi sembrano essere in grado di guardarli per ciò che veramente sono, persone. Persone a cui abbiamo voluto donare qualcosa di nostro, poca roba, un po’ del nostro tempo, per poi accorgerci del fatto che loro hanno arricchito noi pur senza possedere nulla. Uno scambio reciproco che ci ha fatto capire che, quando due realtà così lontane (sia culturalmente che geograficamente) si incontrano, al di là di tutti i dibattiti, le innegabili difficoltà e l’impossibilità di poter dare una ricetta su come risolvere un problema così complicato, non può che sorgere ricchezza. Una ricchezza che brillava nelle lacrime nostre e di quei ragazzi più di qualsiasi diamante sulla faccia di questa terra al momento del congedo.
speranza, una speranza per farli sentire degni di vivere una vita lontano dalla necessità di lasciare la loro terra, la famiglia, gli affetti più cari, affrontando viaggi estenuanti, torture e difficoltà inimmaginabili per arrivare in un posto in cui tutti sono preoccupati di dar loro un’etichetta, ma pochi sembrano essere in grado di guardarli per ciò che veramente sono, persone. Persone a cui abbiamo voluto donare qualcosa di nostro, poca roba, un po’ del nostro tempo, per poi accorgerci del fatto che loro hanno arricchito noi pur senza possedere nulla. Uno scambio reciproco che ci ha fatto capire che, quando due realtà così lontane (sia culturalmente che geograficamente) si incontrano, al di là di tutti i dibattiti, le innegabili difficoltà e l’impossibilità di poter dare una ricetta su come risolvere un problema così complicato, non può che sorgere ricchezza. Una ricchezza che brillava nelle lacrime nostre e di quei ragazzi più di qualsiasi diamante sulla faccia di questa terra al momento del congedo.
È questo il bagaglio in più (oltre a quelli imbarcati in aereo) che ci siamo portati da Casa Aylan, un centro di seconda accoglienza per ragazzi minorenni “sulla carta”. Il fatto di essere minori li tutela, in quanto non hanno bisogno del riconoscimento dello status di rifugiato per poter rimanere sul territorio italiano senza essere rimpatriato. Tale riconoscimento avverrà al compimento della maggiore età quando si deciderà se potranno rimanere o essere rimpatriati, come funziona per tutti gli adulti immigrati che raggiungono le nostre coste. I dodici ragazzi arrivano da svariati paesi dell’Africa, alcuni dal Gambia, altri dall’Egitto (per loro ci sono buone prospettive di rimpatrio), dal Camerun, dalla Costa d’Avorio e dalla Guinea. Sono tutti super gentili e disponibili. Ci abbiamo messo giorni per convincerli che non ci saremmo rotti la schiena se anche avessimo dovuto dar loro una mano con le pulizie o con il riordino dopo i pasti. All’inizio è molto difficile entrare in confidenza con loro. Sono sempre attaccati al cellulare, quel dispositivo che ha permesso loro di rimanere in contatto con la famiglia, con gli amici, che li ha portati a conoscere, attraverso internet, i social network e gli amici che sono arrivati prima di loro, le rotte più sicure e i trafficanti più “affidabili”. Ma che gli ha anche mostrato un’Europa, un’Italia che non esistono, fatte di esagerata ricchezza e opportunità. Tutti e quattro i ragazzi egiziani, per esempio, ci dicono di voler tornare indietro, di essersi imbarcati solo per seguire le orme di tanti altri che stavano facendo lo stesso, per poi accorgersi che forse le cose non sono come si aspettavano. Diversa ovviamente è la situazione dei ragazzi dei Paesi del centro Africa. Nessuno di loro accenna a voler tornare, hanno molta più difficoltà ad aprirsi e a confidarsi. Alla domanda sul perché abbiano lasciato il loro Paese qualcuno ci risponde semplicemente a occhi bassi che è una storia troppo lunga, altri stanno in silenzio,  oppure incalzano con delle battute sul loro Paese per sviare dal discorso. All’inizio pochi ci considerano, pochi hanno voglia di giocare o stare insieme a noi, di parlarci, di sorriderci. Da lì è nato il nostro obiettivo: divertirci con loro, stare nella quotidianità con loro, scherzando, giocando, insegnando e facendoci insegnare qualcosa da loro. I primi giorni praticamente giocavamo tra di noi, poi piano piano si sono aggregati tutti, a grappolo, si sono aperti, hanno iniziato a farci degli scherzi a prenderci in giro, a raccontarci di loro e via dicendo.
oppure incalzano con delle battute sul loro Paese per sviare dal discorso. All’inizio pochi ci considerano, pochi hanno voglia di giocare o stare insieme a noi, di parlarci, di sorriderci. Da lì è nato il nostro obiettivo: divertirci con loro, stare nella quotidianità con loro, scherzando, giocando, insegnando e facendoci insegnare qualcosa da loro. I primi giorni praticamente giocavamo tra di noi, poi piano piano si sono aggregati tutti, a grappolo, si sono aperti, hanno iniziato a farci degli scherzi a prenderci in giro, a raccontarci di loro e via dicendo.
Così è successo anche i due giorni che abbiamo trascorso in un centro di prima accoglienza per ragazze vittime di tratta finalizzata alla prostituzione o al traffico di organi. La situazione qui è leggermente diversa: il centro è di massima sicurezza, non si possono ovviamente scattare foto, le ragazze non hanno cellulare e non possono allontanarsi. Sono quasi tutte minorenni, due di sei anni, altre due con i neonati al seguito. Loro hanno subito voglia di parlarci, di giocare con noi. Le ferite sulla loro pelle parlano da sole, ma chi può sapere quello che si portano dentro, che forse non si rimarginerà come le ferite fisiche. Non parlano italiano perché non vanno a scuola e non fanno nessuna attività al di fuori del centro, a differenza dei ragazzi di casa Aylan che invece possono frequentare le scuole e attività come lo sport o il teatro. Sono quasi tutte Nigeriane, con loro abbiamo comunicato in inglese. Per loro una semplice partita a palla prigioniera è sembrato il gioco del secolo. Sul finale di partita la squadra vincitrice si è messa a cantare e ballare una danza tipica, è stato emozionante – continua nel proprio racconto Davide – Insomma, in linea generale non abbiamo fatto nulla di eroico, nulla di estremamente evidente o degno di chissà quale riconoscimento, ma ci sentiamo di aver dato loro un piccolo barlume di speranza, dal quale attingere per sentirsi ancora, nonostante tutto, ragazzi in grado di amare ed essere amati in quanto persone, persone con vite degne di essere vissute al pari di tutti gli altri, senza la paura di dover nuovamente affrontare quel mare o quel deserto in cui quelle vite hanno rischiato di essere perdute. È in ricordo di tutte quelle persone, e ribadisco persone, che hanno perso la vita in quel mare o in quel deserto, come il piccolo Aylan a cui il centro è dedicato, che abbiamo deciso di donare un piccolo frammento del nostro tempo per dedicarci a questi ragazzi e ragazze, che porteremo per sempre nel nostro cuore. L’augurio è che i volontari che seguiranno le nostre orme a Casa Aylan possano trovare terreno fertile per continuare ciò che noi con il massimo impegno e la massima buona volontà abbiamo iniziato».